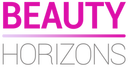IMMAGINA UN FUTURO PULITO ANCHE PER L’AMBIENTE
QUALI STRADE PERSEGUIRE PER DIMINUIRE L’IMPATTO DEI DETERGENTI SULL’AMBIENTE, MAGARI PASSARE DALLA CHIMICA ORGANICA A QUELLA INORGANICA
KEYWORDS
Detergenti chimici
Inquinamento ambientale
Sostenibilità
Fonti inorganiche delle materie prime

Il testo esplora il paradosso tra il piacere della pulizia personale e gli effetti collaterali sull'ambiente derivanti dall'uso di detergenti chimici. Sebbene la pulizia abbia contribuito all’allungamento della vita ed al miglioramento della qualità della vita e della salute umane, i prodotti industriali hanno causato inquinamento, specialmente per quanto riguarda i tensioattivi non biodegradabili che alterano gli ecosistemi. Viene sottolineato che anche i materiali naturali possono avere un impatto negativo. Il testo suggerisce di rivedere le fonti delle materie prime, esplorando alternative inorganiche come argille e minerali, in un'ottica di sostenibilità ambientale. Propone infine una riflessione critica sull’impatto delle scelte quotidiane, invitando a un approccio più consapevole e rispettoso dell’ambiente per preservare le risorse naturali del pianeta.
ABSTRACT
LAVARSI È UN PIACERE, MA COME BERE ALCOOL, FUMARE, MANGIARE MALE, CORRERE TROPPO, PUÒ FAR MALE
Sebbene storicamente e culturalmente il rapporto con la pulizia personale e di ciò che ci circonda non sia sempre stato “cristallino” per la razza umana (basta ricordare il bagno “stagionale” dei cow boys nei film western) a tutti ormai piace un ambiente pulito e ordinato e sentirsi bene puliti e profumati (o almeno liberi da odori corporei).
Tale approccio è ormai stabilito ed accettato sia per quanto riguarda il corpo, gli abiti, gli ambienti, le stoviglie, con le varie declinazioni di prodotti adatti a questo scopo.
È risaputo che le abitudini di lavaggio di tutto ciò hanno contribuito, insieme ai farmaci, al miglioramento dell’alimentazione ed allo sviluppo dei sistemi fognari, all’aumento della aspettativa media di vita dell’umanità, ostacolando il diffondersi delle malattie infettive.
Purtroppo, qualche decennio fa, passato circa mezzo secolo dall’inizio dell’abitudine di lavare accuratamente ogni persona o cosa, si cominciò a capire che c’era un prezzo da pagare.
L’ambiente, soprattutto le acque dolci di superficie e, a seguire, le acque marine e le falde sotterranee, si inquinavano sempre più dei componenti non biodegradabili dei prodotti detergenti che l’industria metteva in commercio.
In quel periodo, l’efficacia detergente era intesa principalmente come utilizzo di detergenti sempre più efficaci, capaci di operare nel minor tempo possibile, senza considerare che nelle operazioni di lavaggio, anche la temperatura e la forza meccanica applicata (una bella strofinata!) sono utili al risultato finale (vedi il Cerchio di Sinner) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).
Si faceva leva sul sogno delle casalinghe: un prodotto che pulisce da solo, senza sforzo e in pochissimo tempo.
La pubblicità si focalizzava sul risultato e sul risparmio di tempo e di fatica, sottolineando il miglioramento delle condizioni di vita delle casalinghe rispetto alle loro antenate lavandaie.
Un prodotto che pulisce da solo, senza sforzo e in pochissimo tempo. Ricordate quella pubblicità di quel “puliscitutto” in cui si immergeva una monetina sporca ed immediatamente ritornava splendente?
Nel processo di lavaggio non ci sono generalmente azioni sui legami molecolari, le sostanze in gioco restano le stesse, ci può essere una diminuzione della carica microbica, ma l’azione dei prodotti di pulizia si compie nell’allontanare lo sporco dalla superficie che si vuole detergere (pelle, pavimento, tessuto e qualsiasi altra superficie) e disperderlo nell’ambiente insieme alle sostanze contenute nel prodotto che si è utilizzato per pulire.
Fino agli anni ’70 del secolo scorso, il tutto, che fosse incanalato attraverso lo scarico della doccia o della lavatrice o dell’industria vicino a casa, finiva allegramente, come le sigarette senza filtro, nel primo corso d’acqua disponibile, con il paradosso che il pericolo maggiore non era più lo sgradevole e diciamo “patogeno” sporco eliminato, ma le sostanze stesse che da questo ci difendono, principalmente gli apparentemente innocenti tensioattivi.
Che questi ultimi non fossero poi così innocenti cominciammo ad accorgercene, ad esempio, sulla riviera romagnola, che, ahimè, raccoglieva in un tranquillo piccolo mare, dalla conformazione simile ad un lago, tutti i reflui, civili ed industriali, della industriosa pianura padana.
“L’immensa pianura sembrava arrivare
Fin dove l’occhio di un uomo poteva guardare
E tutto d’intorno non c’era nessuno
Solo il tetro contorno di torri di fumo”
cantava ai tempi Francesco Guccini e forse, lui, montanaro, aveva un occhio particolare per giudicare la pianura di allora.
NULLA SI CREA E NULLA SI DISTRUGGE
Figura 1. I contaminanti dell'acqua
Vi svelo un segreto, segreto soprattutto alle menti semplici che dicono che non fa male ciò che è naturale e soprattutto a chi va da quella parrucchiera che ha intitolato il negozio “Zero Chimica”: tutto è chimica, anche i prodotti naturali ed anche i prodotti naturali possono fare male all’ambiente.
Cercando di evitare le pietre che stanno cominciando a tirarmi da varie direzioni, cerco di spiegare in maniera semplice, concetti per niente di immediata comprensione.
Punto primo: anche i tensioattivi, che sembrano innocui, possono fare male all’ambiente, perché possono non essere biodegradabili e quindi rimanere non trasformati nell’ambiente e quindi, se non avvelenare, almeno perturbare l’equilibrio ambientale, distruggere specie viventi e cambiare la composizione dei terreni. Possono “drogare” l’alimentazione dei microrganismi e delle alghe (la parola mucillagine vi dice qualcosa?) funzionare come una specie di dopante, e creare microbi paragonabili ad un culturista spinto (8).
Punto secondo: da dove vengono gli atomi che compongono gli ingredienti dei prodotti detergenti che utilizziamo? Andiamo nel profondo. In ultima analisi gli atomi di carbonio, di idrogeno e di ossigeno dei nostri cosmetici provengono principalmente da olio di palma e da petrolio, perché queste due sono le due fonti globali di tali atomi. Potrà esserci qualcosa che viene da qualche gomma naturale, da qualche agrume, ma è poco significativo.
Se andiamo a vedere i processi di trasformazione che portano dall’olio di palma e dal petrolio al prodotto che usiamo nel quotidiano, siamo nel campo della cosiddetta “chimica organica”, che, come mi hanno insegnato a scuola, è la chimica del carbonio tetravalente.
Grandi impianti globali per portare a compimento reazioni sul carbonio tetravalente, con qualche differenza se tale carbonio viene dall’olio naturale o dal petrolio.
Non dimentichiamo tuttavia che la maggior parte degli atomi della maggior parte dei cosmetici sono carbonio e idrogeno che provengono dall’acqua.
ANCHE I GRASSI NATURALI VEGETALI FANNO MALE E ANCHE LORO SONO “CHIMICI”
Figura 1. I contaminanti dell'acqua
Ora, Houston, il problema è che le fonti degli atomi che compongono i prodotti cosmetici (e non solo cosmetici, tutti i prodotti che usiamo) vengono tutte da materiali rarissimi, se consideriamo le dimensioni del nostro pianeta.
Mi spiego.
Il globo terracqueo che ci sostiene ha un volume facilmente calcolabile di circa 1083 (in cifre milleeottantatre) miliardi di chilometri cubi, se non erro quindi, 1,083 per 10 alla 12.
Il volume totale dell’aria, che permette la vita nostra e della palma (oltre a tutto il resto) è di infinitesimi 49 milioni di chilometri cubi, circa 22.000 volte più piccolo del globo terrestre.
Il volume totale dell’acqua che ci dà letteralmente la vita, comprensiva nella sua stragrande maggioranza di acqua di mare salata, di acque superficiali e di falda, è di “soli” 1,386 milioni di chilometri cubi ovvero circa 780.000 volte di meno del globo terrestre (9).
Potrebbe essere la differenza che c’è fra un pallone (la terra), un granello di senape (l’aria) ed un granello di sabbia (l’acqua).
Stiamo vivendo a spese del nulla, estraendo tutto l’estraibile, come, si dice, il sangue dalle rape: se abbiamo bisogno di materiali, li prendiamo da una biosfera sottilissima, a parte il petrolio che è in profondità, ma che sappiamo quanto non sia rinnovabile.
A questa poca acqua e a questa poca aria, restituiamo sostanze che l’ambiente non sempre regge e tanta anidride carbonica, quella che ci serve per scaldarci e muovere le macchine.
HOUSTON, ABBIAMO UN PROBLEMA
Figura 1. I contaminanti dell'acqua
La soluzione potrebbe essere…o almeno un approccio intellettuale potrebbe essere, rivedere con creatività e spirito di adattamento tutte le fonti di materiali che carbonio tetravalente non sono, in altre parole, tutto il regno minerale, che forma la preponderante parte del nostro pianeta.
Non sto scherzando.
Per millenni (ed anche oggi in maniera marginale) composti inorganici sono stati utilizzati per la pulizia.
Mia nonna usava la cenere per fare la lisciva e lavare le lenzuola (durante la guerra di sapone ce ne era poco, di cenere invece, purtroppo, tanta).
Caolino e Bentonite hanno proprietà assorbenti e purificanti.
L’argilla marocchina Ghassoul è un trattamento tradizionale per pelli e capelli (10). Gli shampoo secchi hanno o hanno recentemente avuto un loro ritorno e poi…serve un po’ di creatività e convinzione per proporre prodotti e modalità innovative che spostino l’origine dei materiali dalla chimica organica a quella inorganica.
Se i fiumi porteranno al mare e quindi nel suo fondo, argille al posto di microplastiche, potremmo avere risolto un problema.
Non solo “più scrub e meno tensioattivi” ma anche una ricerca applicata che vada a riformulare i prodotti con attenzione sull’impatto delle scelte che si fanno sulle materie prime, in funzione di un concetto olistico di sostenibilità, così da poter immaginare quello che “Il vecchio e il bambino” immaginavano, prima che diventi solo una fiaba
“Immagina questo coperto di grano
Immagina i frutti e immagina i fiori
E pensa alle voci e pensa ai colori
E in questa pianura, fin dove si perde
Crescevano gli alberi e tutto era verde
Cadeva la pioggia, segnavano i soli
Il ritmo dell’uomo e delle stagioni”
Il bimbo ristette, lo sguardo era triste
E gli occhi guardavano cose mai viste
E poi disse al vecchio con voce sognante
Mi piaccion le fiabe, raccontane altre
LA SOLUZIONE?
Riferimenti bibliografici
- Herbert Sinner, "Die Grundsätze der Reinigung" (1959)
- R. A. McClellan, "Cleaning Science and Technology" (2000)
- D. Walker, "Industrial Cleaning Technology" (2005)
- E. P. Lynch, "The Fundamentals of Cleaning" (2011)
- Journal of Cleaning Technology, "The Evolution of Sinner's Circle" (2010)
- "Application of Sinner's Circle in Cleaning Validation", Pharmaceutical Engineering (2016)
- "Sinner’s Circle: Its Practical Implementation in Modern Cleaning Processes", Journal of Industrial Hygiene (2020)
- https://www.researchgate.net/publication/325961182_Impatto_ambientale_delle_lavastoviglie_e_dei_prodotti_ad_esse_associati
- https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/where-earths-water"https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/where-earths-water
- https://www.vegolosi.it/cosmesi-vegan/ghassoul-come-si-usa-capelli-viso
Figura 1. I contaminanti dell'acqua
“6.8.4 WATER TREATMENT EQUIPMENT SHOULD BE SET UP SO AS TO AVOID STAGNATION AND RISKS OF CONTAMINATION”
Vogliamo terminare questo articolo soffermandoci sul punto 4. Esso, come il punto 1, necessita a nostro avviso di particolare attenzione. Abbiamo già detto che l’acqua purificata tende a ricontaminarsi, questo è tanto più vero tanto più essa rimane statica. E’ altresì importante notare che ciò è valido non solo per il processo di purificazione, ma anche per le fasi di stoccaggio e distribuzione che devono quindi essere altrettanto accuratamente progettate e realizzate. E’ proprio su queste ultime fasi, spesso poco conosciute nella pratica, che vogliamo dedicare il nostro approfondimento.
Si entra qui nel vivo di una parte molto specifica che in ogni azienda varia a seconda dei layout delle aree di produzione, delle abitudini e dei flussi di lavoro, ma ci sono dei criteri che valgono trasversalmente per tutti.
Come garantire quindi che l’acqua purificata prodotta mantenga una qualità idonea fino al momento dell’utilizzo nelle preparazioni cosmetiche?
Innanzitutto, è necessario creare un sistema di ricircolo continuativo (avoid stagnation) a valle del sistema per la purificazione dell’acqua che parta dal serbatorio di stoccaggio e arrivi fino ai punti d’uso per poi tornare di nuovo nel serbatoio, definendo così quello che viene chiamato P&ID (Piping & Instrumentation Diagram). In esso verrà dettagliata la sequenza dei componenti atti al mantenimento dei parametri chiave per la qualità dell’acqua. Di seguito, per meglio chiarirne il concetto, riportiamo un esempio di P&ID:

Il primo elemento rappresentato nel P&ID è il serbatoio di stoccaggio, esso presenta alcune caratteristiche costruttive fondamentali per la conservazione dell’acqua quali: un filtro di ventilazione (tipicamente multistrato, per la rimozione dei contaminanti aerodispersi e della CO2 che causerebbe una lenta acidificazione dell’acqua), un fondo conico per garantire lo svuotamento totale, una spry ball per il lavaggio della parte di testa e delle pareti, una lampada UV e un sensore di livello a pressione. Ognuno di questi accessori verrà collegato mediante connessioni “pulite” che non creino interstizi di ristagno dell’acqua (il tipo di connessione TRI-CLAMP, ad esempio, è ritenuta una delle migliori connessioni in tal senso). L’acqua viene poi spinta verso i punti d’uso, tipicamente le elettrovalvole comandate da un batch-controller e posizionate nei pressi di ogni turboemulsore, mediante delle pompe correttamente dimensionate per garantire una portata e una velocità di flusso sufficienti a generare un moto turbolento all’interno dell’anello di distribuzione. Grazie a questo fenomeno, infatti, si avrà un effetto di autopulizia che renderà molto meno agevole il deposito di biofilm sulle pareti.Dopo essere transitata per i punti d’uso, indipendentemente dal rispettivo utilizzo, l’acqua tornerà al serbatorio e ricomincerà il suo ciclo. Questo permetterà di evitare che l’acqua ristagni nei periodi di inattività produttiva legati ai tempi morti tra una lavorazione e l’altra.Nell’esempio di P&ID in figura abbiamo aggiunto anche alcuni elementi accessori che riteniamo utili al nostro scopo. Essi possono essere definiti di volta in volta a seconda delle specifiche esigenze e sono rappresentati da: un passaggio su UV (il continuo irraggiamento dell’acqua in ricircolo riduce la proliferazione microbica), una filtrazione in linea su filtro 0,22 (si tratta di un filtro assoluto quindi di un’efficacissima barriera al passaggio dei m.o.) e un sistema di campionamento sanitario prima del rientro sul serbatoio per agevolare le operazioni di prelievo microbiologico e migliorarne l’affidabilità. In conclusione, l’esempio di cui sopra potrebbe essere arricchito con molti altri accorgimenti, ad esempio un sistema di abbattimento della temperatura, ma questo tipo di dettaglio esula dallo scopo di questo articolo che intende invece condividere una visione d’insieme per la corretta gestione dell’ingrediente ACQUA, in quanto fattore critico per le esigenze del settore cosmetico dove esso è molto spesso al primo posto nella lista INCI di un prodotto finito raggiungendo percentuali superiori al 60%. La qualità di un prodotto cosmetico è legata a doppia mandata alla qualità dell’acqua utilizzata in produzione che rappresenta quindi un asset fondamentale per lo sviluppo di prodotti premium, innovativi e sostenibili.

ROBERTO LEONARDI
Consulente – cofondatore Progetti e prodotti srl - Italia
EMANUELE PIRO
Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari | Italia

Bio...
Roberto Leonardi
Ho maturato un'irripetibile esperienza in qualità, chimica analitica, regulatory, organizzazione, processi, formulazione, marketing in una azienda di prodotti per estetica professionale.
Poi in una multinazionale ho ricoperto ruoli di responsabilità globale, ideando prodotti per capelli di alto impatto.
Dopo un periodo come consulente sono entrato nell’Ufficio Acquisti Materie Prime di un'importante azienda del make up.
Attualmente ho avviato una nuova stagione imprenditoriale nella consulenza strategica, tecnica e di diffusione prodotti.

MEMBRO DEL COMITATO SCIENTIFICO
di BEAUTY HORIZONS ITALIA
PEER REVIEWED
DETERGENTI IN COSMESI
NEW
spazio
spazio
NEW
(2a PARTE)